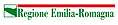di Amanda Rebecca Snyder
Introduzione
Il cinema di Liliana Cavani «non offre acquisizioni sicure ma propone piuttosto degli interrogativi. Esso è volto più a dividere che a suscitare consensi, a problematizzare la riflessione, la considerazione critica».
La criticità che emerge dalle pieghe del suo cinema deriva prima di tutto dallo sguardo libero, spontaneo e demistificatore della regista, votato a «guardare alla realtà senza i manicheismi imposti dal dualismo ideologico con le sue formule aprioristiche di interpretazione della realtà».
Nelle pagine seguenti si è tentato di evidenziare come la libertà di tale sguardo derivi dalla capacità di sfruttare le due opposte possibilità presenti nella pratica cinematografica, quella dell’attestazione di verità dovuta alla natura indicale del mezzo, e quella dell’invenzione artificiosa favorita in primis dal montaggio delle immagini.
Il cinema della Cavani è volto all’emersione della natura ambigua e polisemica dell’immagine filmica-fotografica in quanto traccia del reale: lo spettatore corre spesso il rischio di cadere nella trappola cortocircuitante, predisposta dalla regista con rigore, che lo disorienta tanto da renderlo incapace di distinguere la realtà dalla finzione. Funzionale alla promozione di tale effetto è l’uso “spregiudicato” di alcuni dettagli attinti dal repertorio delle immagini horror in un film come La pelle, in cui sono stati individuati tre momenti privilegiati di fruizione “estrema” dell’immagine.
La regista preme il “pedale” iperrealista anche in Francesco, il secondo film sul santo di Assisi interpretato da Mickey Rourke. Una lettura dell’opera volta ad encomiare la performance della star americana, per quanto possa risultare convincente, può dimostrarsi fuorviante per il riconoscimento d’alcuni aspetti del film la cui soggiacente intenzionalità può ritenersi davvero eversiva. Questo convincimento nasce dalla caparbietà con cui la regista insistette sulla necessità che Francesco d’Assisi fosse interpretato dall’attore americano: «Al produttore non ho lasciato alternative: niente Rourke, niente Francesco».
La nostra proposta interpretativa s’incardina sull’operazione di liberazione da un’immagine-feticcio che la Cavani avrebbe effettuato sull’immagine-corpo di Mickey Rourke. In altre parole la regista avrebbe insistito sulla scelta di Rourke per abbattere l’icona del sex-symbol al fine di liberare il carisma e la spontaneità di un attore di cui ella intravedeva le grandi potenzialità: «Lui ha molta più fede nel mestiere dell’attore di quanto lasci capire».
Anche in quest’ultimo caso ciò che preme sottolineare è la forte ambivalenza dell’immagine, “contesa” dalle logiche dello star-system da una parte, e dalle esigenze diegetiche interne al film dall’altra.
La mise en abîme è, dunque, una delle cifre del cinema di Liliana Cavani in quanto nei suoi film niente è quello che dovrebbe essere, niente è quello che a noi sembra. A proposito del film Milarepa, l’autrice invita a considerarlo come «un viaggio nel labirinto», cioè un mito che «puoi ripetere mille volte perché ogni volta torni indietro con qualcosa di differente dentro di te».
Nell’analisi dedicata a Milarepa si è tentata una lettura originale del film, a partire da un’altra componente che caratterizza alcune opere della regista, ovvero la naïveté delle scelte registiche, che rimandano all’archeologia del cinema, al candore e alla semplicità delle origini; elementi che descrivono lo stesso percorso di formazione dell’asceta tibetano.
Dal cinema delle origini la regista mutua anche l’aspetto spettacolare, la fondamentale ed originaria componente della meraviglia e del divertimento: assistiamo nel film a veri e propri prodigi che fanno subito pensare alle magie cinematografiche praticate dai registi “primitivi” che entusiasmavano il pubblico grazie agli effetti speciali, alle dissolvenze e a tutto il repertorio dei trucchi d’illusione attraverso cui si cercava di riprodurre la dimensione onirica o creare funambolici viaggi immaginari.
L’entusiasmo della Cavani per certe soluzioni deriva da un sentimento religioso di totale apertura e sperimentazione che Pier Paolo Pasolini colse con la sensibilità e l’intelligenza che gli erano proprie: «la Geometria che sintetizza tutti i punti di vista possibili della vita (vissuta e vista vivere) di Milarepa ha, come dire, tecnicamente, i caratteri della visione religiosa del reale, che è appunto sempre polivalente e onnicomprensiva».
In conclusione, attraverso l’analisi dei tre film succitati, ovvero Milarepa, La pelle e Francesco, si contempleranno alcuni aspetti del cinema cavaniano che, dal candore naïf alla crudezza più esasperata, descrivono lo statuto dell’immagine in quanto elemento fortemente ambivalente, cangiante, anzi appositamente predisposto ad evitare quel processo di disambiguazione tipico di ogni atto di simbolizzazione. Così Milarepa, in ragione della propria struttura mitica, diventa passibile di sempre nuove letture; La pelle diviene l’exemplum più raffinato dell’ambiguità tra realtà e finzione che si traduce nello stridore, nell’oscenità e nella non-dicibilità dell’immagine; Francesco è il luogo critico di un’immagine contesa tra il proprio “statuto” di feticcio pubblico e le esigenze “interne” della diegesi.
Milarepa (1973)
Milarepa, film girato dalla regista carpigiana nel 1973, è l’opera che, forse più d’ogni altra, contiene in sé quella componente di naïveté che caratterizza parte della sua produzione e del suo approccio al cinema, a volte ammantato di un candore e di una semplicità disarmanti, che spesso però trovano ragione nello spirito libero, spontaneo e audace della Cavani, come si evince dalle sue dichiarazioni: «Secondo me è importante fare quanto si desidera, non arrendendosi all’idea che sia impossibile», e ancora: «Mi sono abituata a pensare che le cose impossibili sono meno impossibili di quanto si pensi».
Insomma lo spirito pionieristico della regista è ciò che la sostiene nelle sfide più difficili ed è lo stesso, d’altra parte, che in alcuni frangenti la conduce a soluzioni tanto (apparentemente) ingenue da destare una grandissima commozione.
L’amore per il cinema e la fede che in esso ripone sono il motore di quello slancio entusiastico che trapela in modo eccezionale in Milarepa: «Il cinema è la maniera in cui i miei pensieri prendono forma. Se i fratelli Lumière non ci avessero dato il cinema, io sarei stata condannata a non esprimermi e sarei infelicissima oppure in un manicomio». Quest’ultima citazione ci permette di inoltrarci più a fondo nella trattazione osservando che proprio in Milarepa si possono individuare diverse soluzioni registiche che all’archeologia del cinema sembrano ispirarsi e modellarsi: i Lumière, Méliès, il cinema comico americano e le stesse avanguardie russe affiorano come muti ispiratori nella costruzione di alcune scene e sequenze.
Ora, questo rifarsi all’ingenuità e freschezza del cinema delle origini, trova la sua controparte nella stessa filosofia alla base del percorso di saggezza intrapreso dal protagonista. Il “candore” del cinema delle origini rispecchia l’apparente semplicità della filosofia orientale: è necessario regredire in se stessi per ritrovarsi.
Milarepa è il racconto di un viaggio immaginario nelle terre del Tibet di uno studente universitario, Leo, che si identifica nell’asceta tibetano dell’undicesimo secolo Milarepa. Essendo un racconto del tutto immaginato, i luoghi in cui si svolgono i fatti non sono quelli autentici ma ricostruiti dalla coscienza del protagonista che nel film si identificano con le montagne brulle dell’Abruzzo. Anche gli abiti non sono filologicamente attendibili ma frutto dell’immaginazione così come la lingua parlata dai discepoli, un italiano contaminato da un accento straniero.
Ciò che accomuna tutte queste istanze è un’idea di esotismo, non fisicamente esperito ma mentalmente immaginato. Dice bene Ciriaco Tiso quando sottolinea che «Milarepa è l’affermazione dei valori dell’immaginazione, la dichiarazione della felicità del narrare e dell’inventare evitando la fantasia sfrenata; è l’immaginazione che supera il realismo, ma che da esso nasce».
Come non trasporre questo pensiero e il viaggio di Milarepa al cinema delle origini e, perché no, a Le Voyage dans la Lune di Méliès in cui l’immaginazione di un luogo esotico costruito attraverso delle scenografie dipinte fonda il proprio realismo a partire dalla natura indicale del mezzo cinematografico?
In secondo luogo Leo, avendo letto e tradotto il libro Rechung-Milarepa, si immedesima nell’asceta Milarepa e ugualmente proietta «la propria madre come madre di Milarepa, la sorellina come sorellina del mistico, il suo professore e la moglie come il saggio Marpa e signora. Trasporta insomma tutto il proprio mondo nella vicenda del mistico tibetano».
Questo viaggio di continue andate e ritorni tra realtà e immaginazione presenta una geometria cristallina e una corrispondenza perfetta tra i vari personaggi ed elementi del film che Pier Paolo Pasolini elogiò in un intervento assai noto.
E d’altra parte questa stessa corrispondenza degli elementi è costruita su di un rigoroso e omogeneo montaggio cinematografico che, alternando le serie spazio-temporali in maniera manifesta ma senza cedere alla macchinosità, si fa garante del funambolico viaggio rendendo apertamente omaggio alle sperimentazioni degli stessi formalisti russi che, attraverso il montaggio, si dilettavano ad unire parti del mondo molto distanti tra loro dando vivo sfogo all’immaginazione.Per Liliana Cavani il cinema è magia, e ce lo dimostra apertamente allorché Milarepa, su richiesta della madre, apprende la magia nera per vendicarsi dei famigliari che hanno spogliato la sua famiglia di ogni bene dopo la morte del padre. Milarepa si avvia, così, verso la strada della liberazione che gli consentirà di «vedere senza occhi, toccare senza mani, giungere senza camminare»; queste parole riassumono la natura e le potenzialità del mezzo cinematografico che, attraverso il montaggio e in virtù della propria ontologia, permette di solcare distanze spazio-temporali altrimenti incolmabili e provocare fenomeni incommensurabili. È grazie al cinema che Milarepa, con un semplice gesto della mano, è in grado di far crollare una casa intera o seminare morte e distruzione in un villaggio di contadini, il cui “prodigio” egli potrà verificare accompagnato dall’andamento traballante della cinepresa che “simula” un taglio delle riprese in stile reportage.

Una delle scene più commoventi è la resurrezione dei pesci, animali sacri, ad opera di un saggio eremita, il Lama Nyingma, che Milarepa incontra nel suo viaggio.
Il Lama è intento ad abbrustolire alcuni pesci da lui pescati per poi consumarli e finalmente donare loro nuova vita: «Come potrei uccidere delle vite se non sapessi resuscitarle?».
Attraverso un gioco di dissolvenze le lische dei pesci riacquistano carne e vita attestando il potere di resurrezione del cinema. Tale messaggio è reso esplicito dall’effetto “artigianale” del miracolo e pur tuttavia realistico nel suo cosciente atto di fede.Il concetto di resurrezione è particolarmente congeniale ad un discorso sulla natura ontologica dell’immagine filmica tanto da impegnare lo stesso André Bazin, che alla questione dedicò alcuni capitoli del suo Che cosa è il cinema? Il critico francese ravvisava nella morte l’istante qualitativo per eccellenza per la sua unicità e metteva in rilievo come la riproducibilità meccanica di tale evento rasentasse l’immoralità. La Cavani sembra avvalorare, attraverso questo piccolo “saggio” cinematografico, la tesi proposta da Bazin sull’ontologia dell’immagine filmica e guardare con entusiasmo al prodigio, pur esimendosi sempre dal filmare la morte (vera) in diretta. Ed infine veniamo all’incontro di Milarepa con Marpa che segna il degno epilogo di una vera e propria apologia del cinema.Tale incontro si pone subito all’insegna di un rapporto di sudditanza rispetto al maestro che non ha nessuna intenzione di iniziare immediatamente il discepolo alla dottrina. Prima egli dovrà, attraverso mille fatiche e prostrazioni, depurarsi dal karma negativo.
Così Milarepa verrà sottoposto ad una serie di torture fisiche e psicologiche, tra le quali quelle che contemplano la costruzione di una torre, che egli ricostruirà per ben tre volte a causa dell’apparente volubilità del maestro. Ebbene, al di là della serietà intrinseca dell’evento, esso si tinge di note tragicomiche, di un’ironia che «sembra una simpatica trovata per evidenziare tutta l’abnegazione su cui deve far leva Milarepa-Leo, per completare il suo percorso di formazione» .
In realtà questa «simpatica trovata», nella sua struttura sintattica, ricorda molto da vicino certe soluzioni del grande cinema comico quale quello di un Charlie Chaplin o di un Buster Keaton, in cui la comicità deriva dalla ripetizione differente di un unico sintagma figurativo o narrativo. Le gag si distinguono spesso per l’ossessiva ripetitività di una serie di situazioni e per la loro propensione a tendere verso una conclusione catastrofica. Così come avviene per Milarepa che rischia di morire di stenti per realizzare una torre apparentemente inutile.
Oppure si pensi alle potenzialità comiche dell’io arbitrario, lirico e imprevedibile di Chaplin e lo si accosti all’arbitrarietà delle direttive e delle osservazioni di Marpa che si rivolge allo spossato Mila vanificando il suo lavoro: «Demolisci la torre, il posto non è buono. Costruisci là al nord. Se non ti piacciono le mie idee vattene», oppure «Tutto sommato adesso la preferisco quadrata», e ancora: «Ragazzo, con quel rumore disturbi la nostra lettura. Fai piano!» ed infine: «Chi ti ha aiutato a mettere quella pietra lì? Le pietre di questa casa devi metterle tu con le tue mani. Toglila».
Inoltre l’interpretazione di Paolo Bonacelli nel ruolo di Marpa invita ad una lettura anche divertita dell’episodio.Insomma, il percorso di formazione di Milarepa offre l’occasione per una tragicomicità di grande respiro.
La pelle (1981)
La pelle, film girato da Liliana Cavani nel 1981 e tratto dal romanzo omonimo di Curzio Malaparte, racconta dello sbarco a Napoli degli alleati nel 1943.
Paradossalmente si tratta di un film di guerra in tempo di pace: il nemico se n’è andato da tempo e ciò che rimane è una città sconquassata dalla barbarie della guerra in cui la mercificazione dei corpi di donne e bambini è all’ordine del giorno; i prigionieri di guerra sono venduti a peso d’oro; il furto è l’unica pratica possibile per garantirsi la sopravvivenza; persino la procreazione è contro-natura come ci testimonia il parto omosessuale. È un mondo in cui l’orrore diventa ordinario e la normalità un’eccezione secondo la logica infernale del ribaltamento dei valori.
I temi e l’atmosfera veicolati dal romanzo ispirano alla regista carpigiana un linguaggio cinematografico alternativamente grandguignolesco, iperrealista e che non lesina sui dettagli di corpi feriti o squartati attingendo di continuo al bacino di repertori e stilemi del genere horror e in particolare del suo sottogenere splatter, basato sull’estrema realisticità degli effetti speciali, che descrivono lo schizzare del sangue o la lacerazione dei corpi umani, con conseguente fuoriuscita di interiora.
Lo splatter degli anni Ottanta è pure fortemente contaminato con il cosiddetto body horror, ossia un cinema che narra delle deformità fisiche del corpo umano. Una certa fascinazione della regista per quest’ultima componente è confermata dalla presenza nel film di persone con deformità o stranezze fisiche; basti ricordare il fotografo gobbo e dal viso malformato che immortala con uno scatto la danza dei soldati scozzesi; la sirena cotta approntata per la cena «rinascimentale» in onore della moglie del senatore; le donne nane che offrono il loro sesso come un oggetto bizzarro; l’omosessuale “incinto”; la stessa vergine Maria Concetta rientra in questo carosello di “mostri” per il suo imene non ancora lacerato.
Detto ciò, è necessario fare le debite distinzioni e capire come la regista si avvalga di certe desinenze del cinema horror declinandole però in una maniera del tutto personale e foriera di un potere corrosivo straordinario.

Il cinema splatter nasce per individuare e soddisfare i gusti di una fetta di pubblico e quindi per ragioni strettamente legate al mercato. Il suo obiettivo estetico è di disgustare il pubblico. Nelle sue realizzazioni più alte è in grado di farlo ragionare e riflettere sulla violenza presente nella società reale; in particolare il cinema horror degli anni Settanta costituiva l’abreazione di un inconscio collettivo stretto nelle morse psicologiche della guerra del Vietnam. Tuttavia, trattandosi di un genere cinematografico, è caratterizzato da omogeneità e dunque anche da una certa percentuale di prevedibilità che inevitabilmente ne smorza l’efficacia.L’operazione della Cavani consiste nel prelevare chirurgicamente alcuni frammenti dal repertorio delle immagini horror di «serie B» e inserirli con encomiabile raffinatezza su una macchina cinematografica di «serie A», erede della tradizione del cinema classico hollywoodiano e che ammicca anche al neorealismo italiano. La Cavani unisce il sacro al profano, «mescolando l’horror al sentimentale, il sordido del vicolo alla sontuosità dei palazzi patrizi», con una verve genuina e spontanea che raccoglie le diverse ed eterogenee istanze in un eclettismo, se vogliamo anche un kitsch, davvero autentici, mai scadenti nella maniera: «Nel mio lavoro non c’è nulla di premeditatamente teso all’oltranza: probabilmente la vera libertà di cui ho sempre goduto a caro prezzo fa sì che quando il testo pretende certi modi di espressione io li adotti senza timori né autolimitazioni, e sempre con rigore professionale». L’”ingerenza” episodica dei dettagli splatter, nell’economia di un montaggio ben calibrato, crea dunque una frattura nel «contesto armonico» della narrazione filmica producendo un effetto «perturbante»che si potrebbe figurativamente immaginare come uno squarcio nella superficie di celluloide, un momento cioè di stupore, di incanto in cui ci si smarrisce nell’immagine iperreale, nella iper-fiction. Liliana Cavani potrebbe essere a buon diritto considerata la novella Lucio Fontana dell’arte cinematografica. La crudezza dell’immagine deriva dall’epoché, dalla sospensione del giudizio rispetto a ciò che i nostri occhi ci consegnano. Quando la Cavani afferma: «La crudeltà, l’egoismo in senso analitico e quindi il gioco, sono i mezzi per arrivare al realismo» intende dire anche questo: che la violenza, la crudeltà perpetrata ai danni dello spettatore nel senso del comune modo di vedere e percepire il mondo, sono gli unici modi per destarlo e mostrargli la realtà del mondo.A questo proposito sarà utile e illuminante fermarsi su alcuni di questi momenti privilegiati di “destrutturazione” della visione nel film La pelle.Una delle scene più raccapriccianti del film è quella in cui un soldato americano viene sventrato dall’esplosione di una mina. L’intera sequenza è costruita e orchestrata in maniera magistrale al fine di far emergere in tutta la sua carica eversiva il momento clou. Il capitano Malaparte, assieme al capitano Jimmy, è impegnato ad acquistare alcuni rari generi alimentari in occasione del ricevimento di Deborah Wyatt, la moglie del senatore del Massachusetts. Il pranzo contemplerà un «menù rinascimentale in piena guerra mondiale» come afferma con ilarità Jimmy; parole che palesano una situazione grottesca: l’apice del superfluo e della stravaganza convive nello stesso luogo, Napoli, in cui un tozzo di pane è comprato prostituendo donne e bambini.
La situazione è talmente paradossale e portata alle estreme conseguenze che, letteralmente e visivamente, esplode: un soldato americano, con le braghe calate, sta “defezionando” per un bisogno intestinale impellente, esce fuori del campo visivo dello spettatore che ode una detonazione: il soldato ha pestato una mina ed è saltato in aria.Subito dopo scopriamo le sue budella riversarsi sull’uniforme: un vero frammento splatter che abbacina la vista e produce un effetto simile alla pornografia per l’oscenità del taglio “documentaristico” dell’immagine.
E l’oscenità è un tabù come lo è la morte, è qualcosa che non si riesce a comporre cognitivamente come dichiara la stessa regista a proposito dell’esperienza che, ancora bambina, visse di fronte ai cadaveri di alcuni partigiani: «L’immagine di quei morti fucilati mi ha angosciato per lungo tempo. Ma io non me ne rendevo conto… Li ho sognati per molto tempo. E siccome non avevo la religione che mi aiutasse a capire, per me rimaneva un mistero che purtroppo non riuscivo a mettere d’accordo con nessuna ideologia».
In virtù della propria oscenità questo frammento costituisce uno dei pochi momenti “autentici” del film. Il che viene ribadito molto sottilmente poco dopo. Per distrarre il soldato morente il capitano Malaparte e un sergente americano inscenano una commediola farcita di stereotipi: «Hei cumpà!», incalza l’americano, «Chewing gum”, risponde Malaparte e così via: «A’ sta fasù!», «Yankee dollar», «Hei, cazz’in cul». Quindi Malaparte è chiamato ad imitare Mussolini, sempre nell’intento di distrarre il soldato morente. Mani sui fianchi, impettito e imbronciato il capitano recita la sua parte: «Italiani! Italiane! Dopo venti secoli…!». Ma fallisce, non è in grado di proseguire: l’imitazione della realtà non può supplire alla realtà stessa; l’ideologia in quanto contraffazione della realtà non regge di fronte all’oscenità della morte. S’inscrive in questa splendida pagina cinematografica anche una corrosiva critica alla retorica del fascismo.
L’intera sequenza, dunque, si carica di una forza distruttiva dirompente che si abbatte sull’ultima parte della stessa sequenza, portatrice di un’ennesima ideologia.Al primo incidente sul campo minato ne segue un vero e proprio bis.
Pasqualino, il fratello di Maria Concetta, la vergine che ha confortato il soldato morente, sottrae agli americani la valigetta di soccorso e si dirige verso il campo minato. Jimmy lo rincorre e, in uno slancio spettacolare, lo salva da morte certa.
L’evento e il suo lieto fine con Jimmy e Maria Concetta che si sorridono palesa da subito la propria natura di clone, di fac-simile, di realtà edulcorata e riparatrice rispetto al primo incidente. Ed è così che lo stereotipo dell’alleato americano soccorritore del popolo italiano viene completamente demistificato secondo uno dei proponimenti dell’autrice: «La pelle è nato dal libro di Curzio Malaparte, dal desiderio di raccontare una situazione mistificata dai luoghi comuni, che era stata nella realtà più abietta ma più vitale».
Un’altra sequenza di mirabile maestria è quella seguente che s’incardina sul «pranzo rinascimentale» imbandito in onore di Mrs Wyatt, l’aviatrice americana giunta a Napoli alla ricerca di un po’ di fama.
Efferata è l’ironia lanciata verso l’intelligentia americana la cui ignoranza sul paese ospitante è abissale. Il pranzo cosiddetto «rinascimentale» in realtà si tiene in un palazzo settecentesco ed è servito da maggiordomi in abiti pure settecenteschi; la pannocchia di mais consumata dagli ospiti non era certo un alimento prelibato per i nobili del Rinascimento quanto la base dell’alimentazione dei contadini padani dell’epoca; la convinzione dell’ospite d’onore che “Esposito” sia un cognome nobile non viene scalfita nemmeno dalla cortese spiegazione di Malaparte; l’apice del parossismo si raggiunge con la portata d’eccellenza: pesce bollito con maionese.
Ed ecco che qui fa la sua comparsa l’ennesimo inserto splatter che poco più sopra abbiamo precisato afferire al sottogenere body horror.
Il piatto prelibato consiste in uno strano mostro grigiastro dotato di coda e pinne con inquietanti sembianze umane. Ancora una volta lo sguardo dello spettatore viene violentato da un oggetto sulla cui esistenza non si può che dubitare; eppure la sua realtà, il suo esserci qui ed ora viene sottolineato e “comprovato” dalle scelte registiche: il mostro viene offerto alla vista dello spettatore secondo plurimi punti di vista: di fronte, dal didietro e nello scorcio del mento e del seno quasi a volerne dare una visione a tutto tondo, e dunque veritiera, attraverso un procedimento analitico.
Tuttavia l’aspetto forse più interessante è l’insieme dei discorsi, delle affermazioni che descrivono la portata la cui ambiguità e contraddittorietà contribuiscono a promuovere la suspense e a disorientare lo spettatore. Cork lo presenta come «pesce bollito con maionese», «ghiottoneria», «delicato bocconcino»; quindi tale assunzione di significato inizia una parabola discendente che conduce addirittura a negare l’esistenza dell’oggetto, dapprima presentandolo come un essere raro, «una sirena» appunto, poi immaginario, «la sirena che tentò Ulisse», fino a negarne l’esistenza: «le sirene non sono mai esistite». Allorché il fantomatico pesce viene scoperchiato lo spettatore è costretto ad attestare la realtà dell’immagine e di conseguenza la plausibilità di tutti i discorsi che precedentemente sono fioriti su di essa. Così l’ipotesi che si tratti di una «bambina cotta» non ha più credito di quella contraria per cui si possa trattare effettivamente di una «sirena decaduta».
Solo un atto di arbitrarietà può dare allo spettatore il diritto di scegliere nel caleidoscopio semantico dell’immagine. Insomma, siamo di fronte a un saggio metacinematografico in cui la regista afferma la polisemia dell’immagine filmica-fotografica e la sua intima essenza religiosa e politica: «Il cinema è politico solo quando lascia lo spettatore inquieto, dérangé o entusiasta di fronte a qualcosa di irrisolto».
Veniamo ora alla sequenza finale del film per concludere coerentemente la lettura fin qui proposta.
Sulla strada per Roma gli americani, da esemplari “colonizzatori”, si appropriano dell’antica lingua latina per piegarla ai propri fini autocelebrativi come si evince dallo scambio verbale dei due uomini della Quinta Armata americana: «Sic iter ad astra!», esordisce il primo, «Tempus fugit» ribatte il secondo. Il famoso passo virgiliano che significa «Questa è la strada per l’immortalità» viene tradotto con «Questa è la strada per le stelle», dove con “stelle” si intendono le “stellette” della bandiera americana o, in alternativa, le superstar del pantheon hollywoodiano al quale il prode generale Cork avrà presto accesso.
La Cavani non si lascia sfuggire l’occasione per presentare gli alleati tutti intenti ad allestire, alle porte della città eterna, un megagalattico set cinematografico degno di un kolossal americano per accogliere il nuovo Cesare. Così i soldati, divisi in comparse e fotografi di scena, si danno un bel daffare ad immortalare una delle due facce d’America, preparando sullo sfondo un grande cartello con la scritta «ROMA» tutto trapuntato di lampadine che lo fanno assomigliare a un’insegna luminosa di Las Vegas.
Ma tale impalcatura posticcia è destinata a crollare miseramente nella cruente, terrificante e ripugnante immagine dell’uomo triturato dai cingoli del carrarmato, che ancora una volta non può fare a meno dell’iperrealismo del dettaglio splatter.
La crudeltà e l’assurdità della guerra ne La pelle si inseriscono nell’ottica di una “volontà” di perversione del male che ne fa un film epico.
Francesco (1989)
Il cinema scomodo, urtante, stridente della Cavani raggiunge punte iconoclaste in Francesco, diretto nel 1989 con protagonista Mickey Rourke nel ruolo del santo di Assisi.
Film che non è per nulla un remake del primo Francesco d’Assisi ma una creatura nuova il cui motivo ispiratore sembrerebbe essere l’abbattimento di un’icona, di un feticcio quale è il sex-symbol Mickey Rourke, “reduce” da film quali, solo per citarne alcuni, Nove settimane e 1/2 (1986) e Johnny il Bello (1989).

La messe di critiche e polemiche che si raccolse in occasione della presentazione del film a Cannes si appuntava principalmente sulla performance dell’attore protagonista. Ai pareri entusiasti che ne sottolineavano la forza di penetrazione e la straordinaria interpretazione sostenuta da un solido carisma, se ne alternavano altri, più azzardati, che proponevano un parallelismo tra le vite di Rourke e Francesco, entrambi dediti, almeno per una parte della loro vita, a certi rilassamenti morali ed entrambi seduttori seppur di genere diverso… Non mancarono poi le stroncature e le invettive tra le quali una delle più scottanti fu quella lanciata da Carlo Laurenzi per «Il Giornale Nuovo», che descrisse Mickey Rourke come «una stella spenta», i cui occhi «sono lucidi come di pianto o di febbre o magari di sazietà alcolica», con un chiaro riferimento alla sua tormentata vita professionale e privata.
Neppure Tullio Kezich per il «Corriere della Sera» si contenne, osservando che «lo spessore carismatico del personaggio non si ritrova nel playboy pentito Mickey Rourke che… raffigura un Francesco più furbetto che ispirato, più balordo che mistico […] Rourke è quello di 9 settimane e ½».
Positivo o meno il giudizio, il valore del film si misura in base alla capacità di Rourke di convincere.
Insomma l’immagine dell’attore è divisa tra l’ambito professionale-divistico e quello privato in una tensione mai componibile. In questo senso si profila una nuova proposta di lettura dell’opera della Cavani, un’impresa rischiosa, dall’effetto détournante, shockante per lo spettatore, costretto continuamente nell’immane sforzo di sovrapporre o comporre l’immagine minuta e gracile del sant’uomo con quella sensualissima e poderosa dell’attore americano, pena la non credibilità; operazione che è già condensata nei titoli di testa ove il nome dell’attore è seguito dal primo nome del santo, a sottolineare l’intenzione, dal principio della pellicola, di fondere o, meglio, far configgere due individualità.
Mickey Rourke, avvolto negli stracci o nel saio francescano, è prima di tutto un oggetto ready-made, nell’accezione letterale e didascalica del termine, ovvero un comune oggetto di uso quotidiano prelevato dall’artista e posto così com’è in una situazione diversa da quella di utilizzo, che gli sarebbe propria.
Questo concetto è valido su più fronti. Mickey Rourke nel film della Cavani è “decontestualizzato” innanzitutto rispetto ai ruoli comunemente ricoperti; la sua figura inoltre si distingue sommamente da quella degli altri discepoli in quanto è fisicamente più prestante, più alto di statura e porta una capigliatura fine anni Ottanta: tutti elementi che davvero contribuiscono a renderlo un alieno, catapultato in un’altra dimensione spazio-temporale, il che peraltro è la condizione del santo d’Assisi.I comprimari non godono della fama di Rourke e né della stessa presenza fisica, a parte la co-protagonista, Helena Bonham Carter nel ruolo di santa Chiara. Tuttavia la sua notorietà come attrice non entra in conflitto con il ruolo ricoperto. La Carter si è affermata nel panorama cinematografico inglese come attrice particolarmente dotata per ruoli drammatici e la performance nel film della Cavani è in linea con il tipo di personaggio sul quale si è costruita la sua fama, come testimonia, un anno dopo, il ruolo di co-protagonista nel film Amleto (1990) al fianco di Mel Gibson. Ofelia, ruolo congeniale all’attrice, ripropone in parte il modello di Chiara, della donna dall’aspetto gracile, segnata da un biancore spettrale che ne denuncia la femminilità algida e, allo stesso tempo, la profonda sensibilità.
Ma torniamo a Mickey Rourke e alla sua immagine cinematograficamente «eretica». La sfida della regista è di destituire l’immagine dell’attore dalle connotazioni di cui si è detto: il percorso di fede del santo, culminante nel ricevimento delle stigmate, nel Francesco della Cavani è funzionale ad una vera e propria «trasfigurazione» del sex-symbol Mickey Rourke.
La scena in cui Francesco per la prima volta incontra un eretico nelle acque del lago segna l’incipit del suo percorso, caratterizzato da un’abissale lontananza dal messaggio cristologico che si riflette nella bellezza e floridezza del corpo. L’attore che, con il torso nudo, emerge dalle acque del lago dopo il bagno è una compiaciuta celebrazione della sensualità del corpo, dei muscoli scolpiti del pugile Rourke.
Quindi il corpo-Rourke è oggetto di scherno e di ridicolo come testimonia la scena in cui egli si spoglia delle vesti nella contesa giudiziaria col padre e la sua nudità, per la prima volta sugli schermi cinematografici di tutto il mondo, diviene oggetto di riso e di beffa. Quindi lo incontriamo di nuovo mentre chiede l’elemosina subendo l’indifferenza e la scortesia della gente. Ma ciò che sorprende di più è la piccola scodella per la questua che si porta appresso, sproporzionata rispetto al fabbisogno alimentare di cui quel corpo grande e prestante necessiterebbe.
L’umiliazione morale e corporale raggiunge l’apice nella scena in cui i vecchi amici di Francesco gli gettano addosso degli escrementi invitandolo a cibarsene mentre egli, indifeso, subisce l’affronto.Non si può obliare, d’altra parte, la sequenza in cui Francesco-Rourke comprime la neve sui genitali per assopire i bollori carnali, un vero e proprio contrappasso rispetto alla vocazione di seduttore di cui la sua immagine si ammanta.
La prima vera crisi del santo sembra coincidere con la stesura della Regola francescana, considerata troppo dura e disumana dalla crescente comunità di discepoli. È a questo punto che il corpo-Rourke subisce un vero e proprio processo di mortificazione: sul viso compaiono bozze di carne putrescente, gli occhi sono gonfi e arrossati per le lacrime, un biancore spettrale tinge l’incarnato di un uomo che emette gemiti infantili.
L’attore è quasi irriconoscibile tanto la regista ha infierito, tramite il trucco e la direzione di una recitazione tesa e, sul suo volto di larva e per di più insistendo sui primi piani offrendoci la geografia di una terra martoriata e per di più invitandoci a riconoscerne la realtà, sfruttando contemporaneamente le due opposte possibilità presenti nella pratica cinematografica, quella dell’attestazione di verità per la natura indicale del mezzo, e quella dell’invenzione artificiosa; un sodalizio che legittima un viaggio verso i territori dell’immaginario a metà strada tra realistico e illusorio, fantastico e documentario, fedele e infedele.
D’altra parte è la stessa regista che insiste sull’importanza della corporeità nel Francesco: «Vorrei anche dire qualcosa sull’esperienza della fisicità di Francesco, cioè l’espressione della testimonianza non attraverso le parole o le dichiarazioni, ma solo attraverso l’uso del corpo». Declinando tali affermazioni sulla nostra ipotesi potremmo ipotizzare che “vilipendere” il corpo di Mickey Rourke è funzionale al dissolvimento del feticcio che come un’aurea avvolge la sua immagine e, di conseguenza, favorisce l’emersione del carisma più genuino, della natura istintiva e spontanea dell’uomo-Rourke.
Quando la Cavani dichiara: «L’esperienza di Francesco pare quasi un sogno impossibile… Forse ho voluto raccontarla per crederci», forse pensa anche al tipo di operazione sopra descritto: liberare l’attore dalla condizione di asservimento all’immagine fabbricata per lui dalla logica dello star-system attraverso un effetto perturbante. Legittimità a questa proposta è conferita dalle stesse affermazioni della regista: «Faccio di tutto per non commuovere gli spettatori. Non mi interessa fare piangere la gente ma farla riflettere»1.
Il corpo martoriato di Rourke cambia addirittura i connotati, trasfigurandosi appunto, nella scena dell’antro cavernoso in cui si appartano Francesco e Leone. Allorché Francesco gli confessa il contatto con Dio nel «Deus mihi dixit», un primissimo piano ne inquadra il volto e si nota che l’occhio sinistro ha subito un viraggio di colore: è quasi bianco. Non ci si crede, si sente la necessità di stropicciare gli occhi e verificare se non ci si trovi di fronte alla trasformazione di un licantropo, degna di un film horror. Si tratta di una vera e propria epifania cinematografica resa possibile però dalla episodicità degli “effetti speciali”.
Un’ulteriore dimostrazione di come nel cinema di Liliana Cavani, nella oscillazione di opacità e trasparenza della rappresentazione, si incunea la magia del cinema e la sua verità in quanto “traccia” del reale.