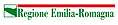Intervista a Liliana Cavani di Silvia Camerini

Incontriamo Liliana Cavani a Roma mentre si prepara per andare a Milano: alla Scala viene ripreso il suo allestimento di Traviata.Quella trionfale Traviata, nata nel 1990, continua dopo 18 anni ad appassionare il pubblico e a fare sempre il tutto esaurito.
Fu una produzione memorabile prima di tutto perché rompeva il malefizio che durava da 26 anni (tanto era il tempo dall’ultima Traviata scaligera): nessuno osava misurarsi con l’interpretazione della diva per eccellenza Maria Callas. Riccardo Muti caparbiamente volle e ottenne il massimo su tutti i fronti. Volle e ottenne Liliana Cavani come regista. E la sintonia tra i due fu perfetta.
La preparazione di Traviata fu lunga e profonda. Con Riccardo a Ravenna ripassammo al piano tutta l’opera, fu uno studio meticoloso che produsse buoni frutti. L’intento era fare una Traviata che risultasse “moderna”, non nell’ambientazione come ovvio, ma nel muoversi sul palcoscenico come ci si muove nella vita. L’importante, come sempre, è adeguare il gesto alla situazione psicologica di ogni momento scenico.
E poi Traviata, che per me è una delle opere più belle mai scritte, è modernissima in sé. Forse è la prima opera “verista” in un momento in cui nessuno sapeva di “verismo”. È passione, tumulto e strazio di sentimenti umanissimi e quotidiani, come il melodramma non aveva mai sentito tanto esplicitamente. Lontanissima da mitologie, epopee eroiche, storie paludate, Traviata racconta un bel fatto di cronaca indicativo di un costume, ed è tutta percorsa da sentimenti privati e intramontabili, quindi immediata. Volevo metterla in scena con tutta la sua verità. Cercavo la naturalezza dei gesti e dei movimenti.
Ho sempre detestato i movimenti a scatto delle masse corali: tutti corrono per entrare in tempo e piantarsi al proprio posto come tante belle statuine, e poi via in fretta come uno squadrone compatto dietro le quinte. Nella festa del primo atto di Traviata il coro va e viene più volte. Io li volevo naturali proprio come i gruppetti di amici che si formano nelle feste: ognuno, rimanendo in scena anche se defilato, aveva un’indicazione precisa di cosa fare, passeggiare discretamente, sussurrare all’orecchio del vicino, dormire sul tavolo perché stanco e ubriaco. Insomma il coro entrava in scena alla spicciolata e faceva qualcosa di piccolo, di naturale, proprio come avrei fatto per una regia di un film.
Sono due mestieri diversi. Nel cinema le immagini vengono create dal regista al momento e la drammaturgia è fatta a pezzettini, non c’è continuità di racconto. Tutti sanno che si può cominciare a girare un film dalla fine perché ci possono essere ragioni di opportunità e di tempo (sfrutti un attore quando e finché è disponibile, puoi utilizzare uno spazio solo in certi momenti…).
Mentre nell’opera il regista non è il padrone, non inventa come invece inventa il film. La musica è davvero vincolante e trascina inscindibilmente con sé l’azione.
Meglio dire che lo sviluppo drammaturgico della vicenda in un’opera lirica è già tutto definito nello spartito. Il regista non deve togliere nè aggiungere nulla, nè cambiare qualcosa. Nel girare un film invece per quanto ci sia una sceneggiatura si possono percepire degli errori cioè qualcosa che manca o che è sbagliato nello sviluppo drammaturgico e quindi, se si è attenti, si può rimediare. Il regista di un film poi sta sempre all’erta perchè può sempre migliorare un dialogo ecc.
Il mio lavoro di cineasta, poi, comprende moltissimi aspetti, non ultimo la ricerca dei finanziamenti. Spesso ci vuole più tempo per trovare i produttori che per girare il film. Poi, individuato l’attore che mi va bene, devo aspettare che sia libero e quindi essere pronta a lasciare ogni altro impegno per dedicarmi tutta al film. Mi è successo di non poter completare un progetto per il Teatro di Zurigo proprio perché si accavallava con Il gioco di Ripley.
Ero a New York al Festival del Cinema nel 1970 assieme a Bernardo Bertolucci. Lui portava Il conformista, io I cannibali.
Questo film ebbe un gran successo, tanto è vero che la Paramount voleva distribuirlo, ma pretendeva di cambiare il finale, insomma voleva il ‘lieto fine’. Io sostenni che non era possibile perché era logico e naturale che i due protagonisti venissero uccisi dalla polizia. Del resto la storia era tratta dall’Antigone di Sofocle. E così non lo comprarono. In sala c’era Giancarlo Menotti che restò colpito dal film e mi dette un appuntamento al Caffè del Plaza. Mi propose di fare un lavoro teatrale a Spoleto ma io non ero interessata al teatro. Scartata la prosa mi disse: «Tu devi fare la lirica», ma non se ne fece niente allora. Dopo degli anni Massimo Bogiankino, che era molto amico di Menotti, mi disse: «Siccome ritengo Menotti un talent scout infallibile, tu devi fare l’opera!» , e quasi a calci mi spinse ad accettare la regia di Wozzeck di Alban Berg che apriva il Maggio Musicale Fiorentino del 1979. Debbo confessare che se non ci fosse stato Bogiankino con tutta la sua insistenza non mi sarei mai avvicinata al teatro lirico.
Io non sono per la traduzione delle opere liriche, perché la voce che canta (il canto umano, è ovvio, si esprime in lingua) deve emettere quei suoni originari che sono generati dalle parole nella lingua in cui è stata concepita l’opera. Traducendo si perde in espressività. La voce è anche musica, è uno strumento che emette quei suoni nella lingua voluta dal compositore. Sappiamo tutti per esperienza che tra il cantare in italiano o in tedesco c’è una differenza come dal giorno alla notte. Certo il pubblico italiano faceva fatica a comprendere il testo… Oggi in teatro si usano i sopratitoli, per fortuna.
Il sovrintendente del Teatro Comunale di Firenze, Bogiankino, volle che Wozzeck fosse tradotto e cantato in italiano, per offrire al pubblico la totale comprensione del testo.
Io non sono per la traduzione delle opere liriche, perché la voce che canta (il canto umano, è ovvio, si esprime in lingua) deve emettere quei suoni originari che sono generati dalle parole nella lingua in cui è stata concepita l’opera. Traducendo si perde in espressività. La voce è anche musica, è uno strumento che emette quei suoni nella lingua voluta dal compositore. Sappiamo tutti per esperienza che tra il cantare in italiano o in tedesco c’è una differenza come dal giorno alla notte. Certo il pubblico italiano faceva fatica a comprendere il testo… Oggi in teatro si usano i sopratitoli, per fortuna.
La scenografia per me è strettamente legata alla psicologia dei personaggi, parla per loro. Pensiamo al cinema espressionista tedesco, ad esempio.
Io racconto un’opera come se fosse un film, così mi sembra di raccontarla meglio.
Quando si cambia l’ambientazione di un’opera, cioè non si seguono le indicazioni delle didascalie, ma la si colloca in un’altra epoca e in un altro contesto, si fa una libera interpretazione assolutamente lecita che può funzionare o meno. A volte non si raggiunge ciò che si voleva, a volte l’idea è proprio sbagliata in partenza. D’altronde ogni regista risponde per la propria cultura e il proprio gusto.
Non amo le attualizzazioni a tutti i costi. L’ho fatto ne La cena delle beffe, nel Werther e nel Macbeth. Pensavo di dare più forza all’opera musicale. Ho attualizzato anche Orfeo ed Euridice ed Alceste.
Quando faccio un Gluck, autore che amo molto, lo faccio contemporaneo a noi perché i suoi temi, che attingono alla grande mitologia classica, sono talmente moderni e attuali da essere astorici. Infatti il mito parla di noi, in qualsiasi tempo noi siamo calati, tratta i grandi temi della vita, del gioire e del soffrire. Mi impressiona la modernità perenne dei tragici greci: in Eschilo c’è già tutto, ed è fondamentale per tutti gli autori venuti dopo. Rappresentare oggi uno di quei testi classici significa dire al pubblico : questo tema è anche tuo, qui e ora. Sinceramente l’ambientazione Grecia classica, o il Settecento, o i manieristi neoclassicheggianti, a teatro, mi annoiano subito.
Ma il problema più grosso quando si affronta Gluck è il finale: secondo le convenzioni della sua epoca i drammi non potevano finire male, e allora ecco arrivare in scena l’immancabile deus ex machina. Oggi per noi questi finali sono un po’ incipriati e falsi.
Purtroppo certo pubblico della lirica, ancora, può essere molto arroccato a difesa di una presunta immutabilità della tradizione. Ho incontrato pubblici col vizio di coltivare le proprie idee e di non essere disposti in nessun modo a rinnovarle. Ad esempio, il Macbeth di Verdi fatto a Parma non è piaciuto. Io avevo voluto scavare nella trama per chiarirla meglio al pubblico. Per esempio, ho visto le streghe come un elemento fondamentale, dramatis persona dell’opera. Le ho viste come delle contadine padane che incontrandosi a lavare i panni parlano tra di loro di quello che captano e lo esprimono tra di loro. Ci sono delle sensitive capaci di percepire il futuro o anche di suggerirlo se interpellate. La gente contadina è rimasta sempre un po’ pagana. Invece al pubblico non sono piaciute. Gradiva le streghe tradizionali, delle pazze con cappelli a punta e barbe e zozze. D’altra parte io devo porgere al pubblico ciò che conosco e mi appartiene. E poi sono convinta che Verdi si sia ispirato alle contadine delle sue terre, che conosceva bene..
Su Wagner ho visto regie assurde. O sono stata sfortunata o non le ho capite. E così mi sono fatta l’idea che non potrei mai realizzare un’opera di Wagner che possa piacere al pubblico.

Intanto ho bisogno di avere io l’idea scenografica di base, epoca e ambiente. Se arrivo a “vedere” l’opera alla quale penso è fatta. Il bravo scenografo la realizza. A volte le immagini arrivano presto nella testa a volte sembra che non arrivino mai. Ricordo che per L’ Ifigenia in Tauride con il bravo Ezio Frigerio, c’era già pronto il progetto di tutti gli atti quando mi capitò di vedere un’immagine del Teatro della Pilotta di Parma. Si cambiò tutto. Frigerio lo realizzò preciso per il Palais Garnier. Con Medea idem. Avevamo già una soluzione con Frigerio. Ma ero infelice. Per caso entrai nel Pantheon e fui affascinata dalla cupola. Portai a Ezio una cartolina su quell’interno e lui accettò la sfida di riprodurre quell’effetto nel teatro al Palais Garnier a Parigi (e poi al Teatro Comunale di Firenze). Tra cinema e opera c’è grande differenza per le scene. Nel cinema gli ambienti nei quali si svolge la scena sono tantissimi. Il cinema scandisce azioni che si svolgono in un susseguirsi di ambienti. Nel teatro (prosa e lirica) c’è una sintesi. La vicenda è raccontata in “atti” che possono essere da 1 a 5-6. perciò, almeno per me, è più difficile “immaginare” i luoghi dove si svolge il dramma esteriore e interiore. Occorrono alla prosa e alla lirica scenografi molto bravi, più che al cinema. Sono stata fortunata. Ne ho avuti due: Ezio Frigerio e Dante Ferretti, coi quali ho fatto anche dei film.
Non basta solo il “bel canto” per dare al pubblico tutta l’emozione che il compositore vuole comunicare. Io cercherei la persona giusta per quel dato personaggio, quella in grado di interpretarne le emozioni, ma in realtà l’ultima parola sulla scelta della compagnia ce l’ha il mio direttore artistico e il direttore musicale. Personalmente, come regista, sono disposta a sopportare anche qualche imperfezione vocale purché ci sia una interpretazione creativa, emozionante sul palcoscenico.
Il più delle volte sono stata fortunata con i miei interpreti, che oltre ad essere ottimi musicisti erano anche buoni attori che riuscivano a dare un’anima ai personaggi.
Come Waltraud Meyer, un’autentica teutonica che doveva interpretare una contadina sicula non proprio emancipata come Santuzza in Cavalleria rusticana, o Shirley Verrett che fu una Medea dall’istinto viscerale, o Tiziana Fabbricini, giovanissima scoperta di Muti per Traviata, che conservava un pudore, una timidezza sua propria che giovò molto allo spettacolo come lo avevamo inteso noi.
Il vero artista interprete è in grado di esprimersi anche con piccoli gesti che nascono spontanei dalla vita. Mi ricordo Eduardo che durante le prove diceva a Pupella Maggio in Natale in casa Cupiello: «Adesso ti alzi, vai verso il comò e ‘agisci’», che voleva dire «fai tutto quello che ti viene, tutto quello che fanno le donne davanti ad uno specchio». Ecco cos’è l’ “agire” sul palcoscenico. Se l’attore è nel ruolo giusto e si convince dell’interpretazione, può “agire” secondo il suo estro: di certo ne usciranno cose esatte e funzionali alla comunicazione teatrale, e aiuterà il pubblico ad avvicinarsi al cuore del personaggio.
Fondamentale tra regista e attore è intendersi, essere chiari e capire cosa si vuole che emerga.
Quando preparo una regia io vivo con quella storia e con quei personaggi, me li faccio entrare in testa, perché solo vivendo con loro posso poi cercare esprimerli.
Oltre che con i protagonisti, io lavoro molto con il coro. Prima di tutto perché voglio spezzare la routine di un repertorio che hanno già fatto decine e decine di volte. Comincio sempre con il raccontare quello che penso di quel dramma che proviamo a raccontare. Nello spiegarlo a loro lo chiarisco anche a me. Il primo turno del coro è una chiacchierata a ruota libera. Quasi sempre ho trovato collaborazione e interesse. Penso che, anche per la loro dignità professionale i coristi desiderino essere dentro ad una situazione con un sapore nuovo e fresco. Poi ritengo che ci sia una psicologia che riguarda la gestualità di una folla, di un gruppo di personaggi. Risolvere il problema del coro immobilizzandolo, come si vede spesso, dà allo spettacolo il sapore dell’oratorio quando invece si tratta di un’azione scenica ricca di coinvolgimento.
 Nei singoli protagonisti, e anche nelle masse corali viene evidenziata l’intimità del dramma più che la sua spettacolarità.
Nei singoli protagonisti, e anche nelle masse corali viene evidenziata l’intimità del dramma più che la sua spettacolarità.Così si chiarisce e si esprime il dramma che nella sua essenza è gioire e soffrire, proprio come nella vita. Le astrazioni, in generale, mi annoiano a guardarle quindi non le porgo neanche.
Mia madre fin da bambina piccola mi portava al cinema. Non avevamo la stessa consuetudine con la prosa. In un certo senso nella mia formazione non c’è niente che faccia riferimento al teatro di prosa. Il teatro che amo è quello mediato dalla vita, quello di Strehler, della Compagnia dei Giovani, e soprattutto di Eduardo. Mentre il teatro intellettualistico astratto mi annoia a morte. Ho amato molto tuttavia il Living Theater: Judith Malina e Julian Beck hanno insegnato a tutti riproponendo il teatro come cerimonia e come ebbrezza, come era in antico.
Mi piaceva anche Bob Wilson, all’inizio, perché sapeva creare un’atmosfera stupenda, carica di un’emozione che resisteva al passare del tempo (spettacoli lunghissimi), poi col tempo la forza di quell’intuizione è diventata maniera. Gli feci anche un provino per Milarepa, ma non era il personaggio giusto.
Nel ’69 ero a Milano a girare I cannibali e vennero a trovarmi in albergo Paolo Grassi e la Vinci. Mi proposero di fare un lavoro a mia scelta al Piccolo Teatro. Ero imbarazzata a dire di no. Il teatro lo conoscevo quasi solo attraverso la letteratura e dissi che avrei pensato a qualcosa. Mi venne in mente Wallenstein di Schiller. Dissi che ci avrei pensato. Poi quel Wallenstein cominciò a incastrarsi nella mia testacon una soluzione così assurda e costosa che lo ricacciai indietro e così dopo un paio di settimane risposi ai gentili Grassi e Vinchi che non avevo tempo.
Decidemmo di trasmettere in diretta l’apertura della Scala. Penso che il Macbeth di quel 7 dicembre fosse bellissimo, in teatro, dal vivo, ma visto nel piccolo schermo fu un disastro perché si vedevano solo spigoli, frammenti della scenografia che era un grande cubo misterioso. Abbiamo avuto il più basso share della storia della TV nazionale. Ci sono regie e scene che sono assolutamente inconciliabili con il linguaggio televisivo, attraverso la telecamera si perde la suggestione dello spazio teatrale.
È raro che il cinema riesca ad offrire al pubblico il tipo di emozioni che l’opera diffonde dal palcoscenico e dall’orchestra. Direi che anche i fruscii del pubblico sono parte di tutto l’insieme. Ciò nonostante Bergman fece un commovente Flauto magico e Losey un affascinante Don Giovanni. Bergman e Losey sono riusciti a tenere viva la leggerezza e la fragilità del lavoro teatrale. Altri che ci hanno provato non sono riusciti, perchè hanno voluto strafare spettacolarmente. Mi proposero un Orfeo e lo avrei fatto volentieri e già pensavo dove girarlo. Ma la produzione reduce da insuccessi nel settore, chiuse i battenti prima che lo cominciassi.