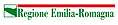La Nuova Sardegna — 15 dicembre 2008
pagina 21 sezione: spettacolo
«Stavo per fare un mestiere noiosissimo: filologa del linguaggio. Arrivai a Roma, dopo la laurea per una specializzazione alla biblioteca vaticana. Ma poi feci il Centro sperimentale di cinematografia: forse influenzata dai film che mia madre mi faceva vedere fin da piccola». Esordisce così Liliana Cavani, di fronte al pubblico della Cineworld di Cagliari che poi assisterà ad uno dei suoi film più controversi e misteriosi, “Interno berlinese”, tratto dal romanzo del giapponese Tanizaki, “La croce buddista”. Ospite dell’associazione L’Alambicco, che ha organizzato una bella retrospettiva dei suoi film, premiata dall’Assessore alla cultura del comune, Giorgio Pellegrini, con un libro-scultura di un’autrice sardo-modenese, invitata a pensare ad un film su Cagliari, o sulla Sardegna, la regista emiliana precisa di non essere attualmente in grado di progettare un film sardo, visto che non conosce l’isola, e non vorrebbe cadere nell’ovvio o nello stereotipo esotico-turistico. Più tardi, in una chiacchierata amichevole, preciserà che forse ci sono storie nascoste, anche in quest’isola, che meriterebbero un film “al presente” o al “passato”: ad esempio la storia delle molte basi militari sparse nel territorio. Ma il senso del suo intervento, tra incontro pubblico e intervista, sta forse nell’inanellare ricordi e precisazioni sui propri, anche quelli non fatti (ad esempio un “Pendolo di Focault”, scritto e riscritto, fino a quando non apparve “Il Codice da Vinci”), ma soprattutto di quelli che sono rimasti a rappresentare, in massimo grado, la sua carriera. Ad esempio, la trilogia tedesca (“Portiere di notte”, “Al di là del bene e del male”, e appunto “Interno berlinese”), volontariamente tesa ad una provocazione culturale: «In Italia non si parlava né di Nietzsche, se non a livello accademico, e in quegli anni, neanche del nazismo come portato psicologico, come cultura dell’ambiguità e delle apparenze. Quando ho girato “Il portiere di notte” non era stato ancora tradotto in Italia il celebre “La banalità del male” di Hanna Arendt e nemmeno Susan Sontag aveva scritto sul “fascino del fascismo”. Io scelsi come protagonista un nazista, e pure bello come Dirk Bogarde, e raccontai il lato erotico, seduttivo, perverso, ma umanissimo, del nazismo, quello che porta poi i due protagonisti alla perdizione. Insomma, il bene e il male come concetti legati alle culture di determinate società: anche in “Interno berlinese”, si parla della bellezza, un concetto chiave nell’ideologia nazista della purezza della razza che pure diventa una minaccia politica. E dopotutto l’idea chiave del bene e del male c’è anche in Milarepa, che affronta un testo lontano anni luce della cultura occidentale». Il cuore del suo racconto riguarda però quasi un dato autobiografico: l’essere una delle poche figure femminili di spicco (o forse l’unica) del cinema italiano del dopoguerra e la sua fama di cattolica conciliare, ovvero del dissenso, come si diceva negli anni Sessanta. Il primo punto viene liquidato in poche battute: «Non ho mai sentito il problema di essere una donna nel mio lavoro di regista. Sarà stata la mia origine familiare, la libertà di cui godevo in famiglia, ma direi che sul piano personale non ho neanche avuto rapporti con il femminismo. Le difficoltà come regista sono state tutte di tipo produttive: le stesse che potevano avere Bellocchio o altri della mia generazione. Facevamo film scomodi, non amati dall’establishment». Sul secondo punto, la Cavani, è ancora più dura: «Il mio presunto cattolicesimo fu un travisamento giornalistico. Io provenivo da una famiglia operaia, laica e antifascista. A Carpi non eravamo neanche anticlericali come a Bologna, dove ha pesato la dominazione dello Stato pontificio. Semplicemente non c’era un problema religioso o di appartenenza cattolica. L’equivoco è nato dopo la produzione di “Francesco D’Assisi”, un filmato Rai che segnò il mio esordio nel lungometraggio a soggetto. Prima di allora, sempre per la Rai, avevo fatto cose diversissime: un documentario sul Terzo Reich ed uno su Stalin, ma soprattutto un film-inchiesta sul problema della casa che aveva suscitato un mare di polemiche e che fu anche un censurato. Poi mi fu proposto di girare un film su San Francesco ed io accettai la sfida. Non fu facile e il film uscì nelle sale proprio grazie all’intervento di alcuni esponenti del cattolicesimo dossettiano - oggi si chiamerebbero cattocomunisti - che contavano abbastanza in Rai, in quel periodo. Stranamente erano protetti da un democristiano vero come Bernabei, che però coltivava quel gruppo di “intelligenze” cattoliche non schierate. Da qui è nata l’etichetta di cattolica di sinistra, tipica di una cultura come quella italiana del dopoguerra che non consentiva una vera autonomia intellettuale». «D’altro canto - prosegue Liliana Cavani - quando a Roma entrai nel giro degli autori-intellettuali, scoprì un’altra chiesa, quella comunista, anch’essa inquadrata rigidamente, e naturalmente fui bollata anch’io come comunista, anche se litigavo furiosamente con questi. L’unica persona realmente libera fu, non a caso, Pasolini, che scrisse la famosa poesia sui poliziotti “figli del popolo” e sugli studenti borghesi, dopo aver visto proprio l’ambiente borghese degli intellettuali di sinistra. Ma forse la mia rottura con quei mondi contrapposti avvenne dopo un viaggio a Praga. Presentai “Francesco d’Assisi”, conobbi molti intellettuali del dissenso, tra cui Milos Forman, con il quale sono rimasto sempre in contatto, e ne ricavai una profonda impressione: l’atmosfera faceva paura, anche se i carri armati sovietici sarebbero arrivati solo l’anno dopo, ma la gente voleva essere libera, non sopportava proprio il comunismo. Al mio ritorno in Italia, non riuscì minimamente a ragionare su queste cose con i miei amici comunisti. L’ideologia era più forte di tutto». E oggi? «La società italiana è cambiata - dice la regista - ma purtroppo non in meglio, ed è sempre difficile essere autonomi, non schierati. Alle divisioni ideologiche si è sostituita una sorta di poltiglia in cui sono immersi tutti. Se oggi penso al primo Francesco, posso dire che é stato il mio vero contributo al ’68, dunque abbastanza lontano dall’ideologia. Poi ci sono tornata, vent’anni dopo, con il Francesco interpretato da Rourke: ho scelto io di farlo come per proseguire il discorso sull’uomo Francesco da un altro punto di vista. Ciò che è rimasto del suo messaggio, del suo essere uomo in senso totale e non solo santo». - /Gianni Olla/